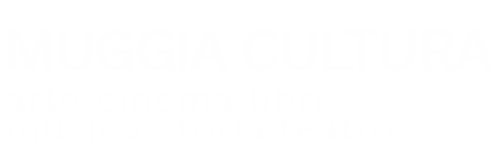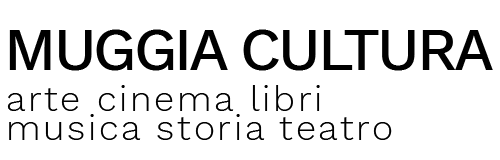Venerdì 31 gennaio alle 18 inaugura al Museo d’Arte Moderna “Ugo Carà” la mostra storico-documentaria “Città nascoste, atlante dei campi profughi di Trieste 1947-1975”, realizzata da ANVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, CDM, Centro di Documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata, FEDERESULI, Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani Fiumani e Dalmati, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Trieste, e curata dallo storico muggesano Francesco Fait, ricercatore indipendente, nell’ambito del Giorno del Ricordo, visitabile a ingresso libero fino a domenica 16 febbraio 2025 da giovedì a sabato 10-12 e 17-19, domenica e festivi 10-12.
Con la nota bipartita dell’8 ottobre 1953 i governi di Stati Uniti e Gran Bretagna annunciano la volontà di abbandonare la Zona A del mai costituito Territorio Libero di Trieste per consegnarla al governo italiano in tempi non definiti ma vicini. Il destino della Zona B è segnato e quello che fino a quel momento era un flusso, anche copioso, diventa una marea oceanica: migliaia e migliaia di istriani lasciano la Zona B e raggiungono Trieste sistemandosi, nella maggior parte dei casi, presso parenti, amici, locatari, quasi sempre in spazi angusti e sovraffollati, non di rado sottotetti e cantine. Una parte minoritaria, ma sempre ingentissima, viene prese in carico dalle autorità, in primis la Prefettura e il Commissariato generale del Governo presso il quale viene costituito il CRP, Centro Raccolta profughi di Trieste.
Al loro apice nel 1956, i centri simultaneamente in funzione saranno circa trenta: alloggi pubblici e scuole sottratte alla loro destinazione d’uso, case private e alberghi requisiti, fabbriche in disuso, scuole, caserme, campi di baracche e campi di edifici in muratura. Si tratta di agglomerati di dimensione varia, che soprattutto nel caso dei campi baraccati assumono i tratti di vere e proprie città, con una viabilità interna, chiese, scuole, servizi sanitari e attività commerciali. Città talvolta di dimensioni ragguardevoli, come nel caso di Padriciano che supera i 3.400 abitanti. Città nascoste, sebbene in molti casi situate in pieno centro cittadino: sia in quanto di norma bandite ai triestini, sia in quanto tenute “segrete” dagli stessi abitanti che salvo casi eccezionali non parlano del loro status con nessuno se non con i propri compagni di avventura (o di sventura).
La mostra rappresenta la tappa intermedia di un progetto di ricerca che è al contempo progetto di attivazione sociale. Essa mira a raccontare in modo nitido e rigoroso ma accessibile l’epopea drammatica e in un certo senso gloriosa dei campi profughi del territorio di Trieste, da Muggia (Punta Sottile) a Duino (Villaggio del Pescatore). Si tratta di una ricerca in cui la “Storia” e la “Memoria” si connettono intersecandosi.
Per prima viene la “Storia”, indispensabile per mettere a fuoco il tema attraverso i mezzi tradizionali della ricerca storica ossia, prevalentemente, lo studio delle fonti bibliografiche e soprattutto documentarie che si trovano presso i vari archivi (Archivio di Stato di Trieste, Archivio Storico del Comune di Trieste, Archivio Storico del Comune di Muggia, Catasto dei terreni e Ufficio Tavolare). E in questo senso, l’esito della ricerca è stata la schedatura del più alto numero possibile di strutture e la restituzione cartografica delle principali e più rappresentative.
E dopo la “Storia” la “Memoria”, raccolta in un congruo numero di interviste appositamente realizzate con le persone che vissero nelle strutture del C.R.P, talvolta essendovi nate. Si tratta in questo caso di testimonianze imprescindibili, fonti complementari rispetto alle archivistiche ma essenziali per restituire la complessità di quelle vicende e di quelle esistenze, sicuramente drammatiche ma non di rado culminanti in episodi e vicende di fratellanza, amicizia, convivialità e socialità.
Il percorso espositivo si snoda in sezioni. La prima, “Mappe”, offre le coordinate principali del fenomeno, presenta riproduzioni di documenti dell’epoca posseduti dall’Archivio di Stato di Trieste e le ricostruzioni cartografiche inedite e prodotte per l’occasione di quattro campi: Padriciano, Santa Croce, San Sabba e Noghere. La seconda sezione, intitolata “Rotte”, propone stralci di interviste di ex profughi e loro foto “vernacolari”. La terza, “Approdi”, accenna, nuovamente grazie a fonti dell’Archivio di Stato di Trieste, alla vicenda delle “colonie” agricole di Fossalon, San Quirino, Roveredo, Maniago, Bibione, in cui vennero insediati contadini istriani. Infine la quarta, “Barche senza timone”, che presenta una piccola selezione di richieste e proteste vergate nei campi e recapitate alle autorità. In mostra anche una selezione di filmati dell’Istituto Luce, in grado di fornire informazioni di base sul contesto storico e restituire il clima dell’epoca e un’ulteriore, preziosissima, fonte: le riprese amatoriali del Silos realizzate da Giuseppe Fucci, tuttofare del Silos dal 1954 al 1957 e cineamatore.
La mostra rappresenta la fase intermedia del progetto, il cui esito finale è la pubblicazione di un volume che avverrà auspicabilmente alla fine del 2025. Ciò significa che tutti gli interessati sono ancora in tempo di partecipare al progetto facendosi intervistare e mettendo a disposizione le proprie foto “vernacolari”.
https://www.museougocara.eu/en/events/citta-nascoste-atlante-dei-campi-profughi-di-trieste-1947-1975